|
|
In occasione del centenario della nascita il settimanale comunista catalano *realitat propone una monografia dedicata alla figura di Manuel Sacristán, intellettuale comunista pioniere nella diffusione, nello Stato spagnolo, delle idee ecologiste e della decrescita. La monografia è stata curata dal mio amico Victor Rios, storico e ricercatore presso il Centro Studi sui Movimenti Sociali dell’Università Pompeu Fabra. Vi propongo il suo articolo che apre il numero monografico della rivista.
Ho conosciuto Manuel Sacristán quando mi sono iscritto alla Gioventù Comunista, nell’anno accademico 1967-68. La commissione di formazione del PSUC ebbe il compito di aiutarci nei nostri primi passi nel mondo del comunismo catalano. Ricordo come Sacristán ci guidava nella lettura del Manifesto del Partito Comunista, insegnandoci a leggere i nostri classici in modo critico e attuale e, quindi, insegnandoci a pensare.
Continue reading Victor Rios: Manuel Sacristán, un comunismo per il XXI secolo
 Ursula von der Leyen La corsa dell’Unione Europea ad aumentare la spesa militare è intesa tanto a compiacere Washington quanto a raggiungere una vera e propria “autonomia strategica”. Lo scrive Harrison Stetler sulla rivista statunitense The Nation.
Sembra passata una vita da quando il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama rimproverò alle sue controparti europee di essere “ pigre” in materia di spese militari, avvertendo che l’austerità fiscale, in seguito alla crisi dell’Eurozona del 2010, avrebbe ostacolato la capacità degli Stati europei di svolgere un ruolo più ampio nella loro difesa.
Era un assaggio delle cose che sarebbero accadute. Sebbene il sostegno all’Ucraina da parte dell’amministrazione di Joe Biden avesse fatto svanire i timori di un ritiro americano dall’Europa, queste speranze sono state spente con il ritorno fragoroso di Donald Trump alla Casa Bianca. Da gennaio, Trump ha rapidamente inasprito le critiche nei confronti dei tradizionali alleati degli Stati Uniti nell’Unione Europea, aprendo al contempo negoziati con Mosca, sopra le teste delle capitali dell’UE e di Kiev. Quando è trapelata la notizia di Jeffrey Goldberg, che ha mostrato i vertici dell’amministrazione Trump deridere privatamente la dipendenza europea – “È PATETICA”, ha scritto il capo del Pentagono Pete Hegeseth – c’era poco che le élite dell’UE non dovessero già sapere. Continue reading Harrison Stetler: Il labirinto del riarmo europeo
 Vi propongo un articolo scritto nel 2000 dal filosofo ungherese GM Tamás (1948–2023), il più noto oppositore intellettuale di Orban. L’articolo di Tamás contiene molti elementi utili per un’analisi dell’ultradestra internazionale. Tamás ne vedeva lo sviluppo con nuove caratteristiche. Sosteneva che ovunque nel mondo contemporaneo stava emergendo un fascismo post-totalitario che sopravvive senza Führer, senza partito unico, senza SA o SS. Il postfascismo – secondo Tamás – trova facilmente la sua nicchia nel nuovo mondo del capitalismo globale senza sconvolgere la democrazia elettorale. Ovunque le minoranze immigrate e persino quelle autoctone sono diventate il nemico. Tagliare in due la comunità civile e umana: questo è fascismo. Tamás metteva il dito in un dato reso ancor più evidente dal migranticidio nel Mediterraneo come dal genocidio a Gaza: oggi la cittadinanza è un privilegio del tutto eccezionale riservato agli abitanti dei fiorenti stati nazionali capitalisti. Come illustra la traiettoria di Orban, ci troviamo di fronte a una nuova forma di estremismo di centro. Orban dopo essere stato per tanti anni nel PPE è ora collocato nel gruppo dei Patrioti per l’Europa con l Pen, Salvini e Abascal. Bisognerebbe raccogliere in un libro per il lettore italiano gli scritti di Tamás. Segnalo un suo articolo sulla rivoluzione ungherese. Vi propongo un articolo scritto nel 2000 dal filosofo ungherese GM Tamás (1948–2023), il più noto oppositore intellettuale di Orban. L’articolo di Tamás contiene molti elementi utili per un’analisi dell’ultradestra internazionale. Tamás ne vedeva lo sviluppo con nuove caratteristiche. Sosteneva che ovunque nel mondo contemporaneo stava emergendo un fascismo post-totalitario che sopravvive senza Führer, senza partito unico, senza SA o SS. Il postfascismo – secondo Tamás – trova facilmente la sua nicchia nel nuovo mondo del capitalismo globale senza sconvolgere la democrazia elettorale. Ovunque le minoranze immigrate e persino quelle autoctone sono diventate il nemico. Tagliare in due la comunità civile e umana: questo è fascismo. Tamás metteva il dito in un dato reso ancor più evidente dal migranticidio nel Mediterraneo come dal genocidio a Gaza: oggi la cittadinanza è un privilegio del tutto eccezionale riservato agli abitanti dei fiorenti stati nazionali capitalisti. Come illustra la traiettoria di Orban, ci troviamo di fronte a una nuova forma di estremismo di centro. Orban dopo essere stato per tanti anni nel PPE è ora collocato nel gruppo dei Patrioti per l’Europa con l Pen, Salvini e Abascal. Bisognerebbe raccogliere in un libro per il lettore italiano gli scritti di Tamás. Segnalo un suo articolo sulla rivoluzione ungherese.
Ho un interesse da dichiarare. Il governo del mio Paese, l’Ungheria, è – insieme al governo provinciale bavarese (provinciale in più sensi) – il più forte sostenitore estero dell’Austria di Jörg Haider. Il gabinetto di destra di Budapest, oltre ad altre malefatte, sta tentando di sopprimere la governance parlamentare, penalizzando le autorità locali di colore politico diverso dal suo, e creando e imponendo una nuova ideologia di Stato, con l’aiuto di alcuni intellettuali di estrema destra, tra cui alcuni neonazisti palesi. È in combutta con un partito fascista apertamente e ferocemente antisemita che, ahimè, è rappresentato in parlamento. Le persone che lavorano per l’ufficio del primo ministro sono impegnate in un revisionismo dell’Olocausto più o meno cauto. La televisione di Stato, controllata dal governo, dà sfogo a un crudo razzismo anti-zingaro. I tifosi della squadra di calcio più popolare del Paese, il cui presidente è un ministro del governo e un leader di partito, cantano all’unisono sul treno che sta per partire da un momento all’altro per Auschwitz.
Al piano terra della Central European University di Budapest è possibile visitare una mostra sugli anni di tumulti di una decina di anni fa. È possibile vedere un video registrato illegalmente nel 1988, in cui si vede l’attuale primo ministro ungherese che mi difende e mi protegge con il proprio corpo dai manganelli dei poliziotti comunisti in assetto antisommossa. Dieci anni dopo, questa stessa persona ha nominato un generale della polizia comunista come suo ministro degli Interni, la seconda o terza persona più importante del gabinetto. I conflitti politici tra ex amici e alleati sono solitamente acrimoniosi. Questa non è un’eccezione. Sono un partecipante attivo di un nascente movimento antifascista in Ungheria, intervengo a raduni e manifestazioni. I nostri avversari – in termini personali – sono troppo vicini per avere un po’ di conforto. Non posso quindi considerarmi un osservatore neutrale.
Il fenomeno che chiamerò post-fascismo non è esclusivo dell’Europa centrale. Tutt’altro. Di sicuro, Germania, Austria e Ungheria sono importanti, per ragioni storiche evidenti a tutti; frasi familiari ripetute qui hanno echi diversi. Ho visto di recente che la vecchia fabbrica di mattoni nel terzo distretto di Budapest sta venendo demolita; mi è stato detto che al suo posto costruiranno una comunità recintata di ville suburbane. La fabbrica di mattoni è dove gli ebrei di Budapest aspettavano il loro turno per essere trasportati nei campi di concentramento. Si potrebbero anche costruire cottage per le vacanze a Treblinka. La nostra vigilanza in questa parte del mondo è forse più necessaria che altrove, poiché l’innocenza, in termini storici, non può essere presunta. 1 Tuttavia, il post-fascismo è un insieme di politiche, pratiche, routine e ideologie che possono essere osservate ovunque nel mondo contemporaneo; che hanno poco o nulla a che fare, tranne che nell’Europa centrale, con l’eredità del nazismo; che non sono totalitarie; che non sono affatto rivoluzionarie; e che non si basano su violenti movimenti di massa e su filosofie irrazionaliste e volontaristiche, né giocano, nemmeno per scherzo, con l’anticapitalismo.
Perché chiamare fascismo questo insieme di fenomeni, per quanto post-fascismo?
Il post-fascismo trova facilmente la sua nicchia nel nuovo mondo del capitalismo globale senza sconvolgere le forme politiche dominanti della democrazia elettorale e del governo rappresentativo. Fa ciò che considero centrale per tutte le varietà di fascismo, inclusa la versione post-totalitaria. Senza Führer, senza governo monopartitico, senza SA o SS, il post-fascismo inverte la tendenza illuminista ad assimilare la cittadinanza alla condizione umana.
Continue reading GM Tamás: Sul postfascismo (2000)
 Trump con i dazi scarica sul resto del mondo la responsabilità della de-industrializzazione degli Stati Uniti. Come al solito i fascisti dirottano sul nazionalismo il malcontento che suscitano le contraddizioni del capitalismo. Invece di prendersela con i loro capitalisti i proletari statunitensi bianchi vengono spinti a prendersela da un lato con gli immigrati, la cultura woke, le minoranze sessuali e ovviamente dall’altro con gli altri paesi capitalistici che farebbero concorrenza sleale. Trump con i dazi scarica sul resto del mondo la responsabilità della de-industrializzazione degli Stati Uniti. Come al solito i fascisti dirottano sul nazionalismo il malcontento che suscitano le contraddizioni del capitalismo. Invece di prendersela con i loro capitalisti i proletari statunitensi bianchi vengono spinti a prendersela da un lato con gli immigrati, la cultura woke, le minoranze sessuali e ovviamente dall’altro con gli altri paesi capitalistici che farebbero concorrenza sleale.
Trump e l’ultradestra attaccano il globalismo come se fosse un’invenzione della sinistra radicale e dei marxisti, degli europei o dei cinesi, dei canadesi o dei giapponesi, degli indiani o dei messicani. In realtà la globalizzazione è stata portata avanti dalle élite capitaliste USA a partire dalla fine degli anni ’70 come risposta alla forza delle classi lavoratrici e popolari dell’Occidente. Questa controrivoluzione fu un progetto politico, come insegna David Harvey, che si affermò con la vittoria del presidente repubblicano Ronald Reagan e con quella di poco precedente di Margareth Thatcher in Gran Bretagna. Se gli operai negli USA o in Europa avevano conquistato una forza contrattuale difficilmente aggirabile, se le classi popolari rivendicavano un sempre più alto livello di welfare da finanziare con una tassazione più alta dei capitali e dei patrimoni, se gli Stati intervenivano sempre più regolando la sfera economica limitando il potere del capitale per la classe miliardaria si era di fronte alla “crisi della democrazia”, come titolava il famigerato rapporto della Commissione Trilateral. E quindi bisognava delocalizzare le produzioni all’estero e liberare il capitale dai lacci e lacciuoli degli Stati nazionali troppo condizionati dai partiti di sinistra, dei sindacati e dei movimenti sociali.
In seguito anche i Democratici si adeguarono con il clintonismo. Dopo aver resistito negli anni ’80 con il crollo del Muro anche le socialdemocrazie europee si adeguarono raggiungendo la totale assunzione di quella logica con Blair e Schroeder. Dal 1991 la Russia e i paesi dell’Europa orientale furono definitivamente integrati nell’economia globale con terapie shock di privatizzazione. Continue reading Trump non la conta giusta. E’ il capitalismo USA ad aver voluto la globalizzazione neoliberista
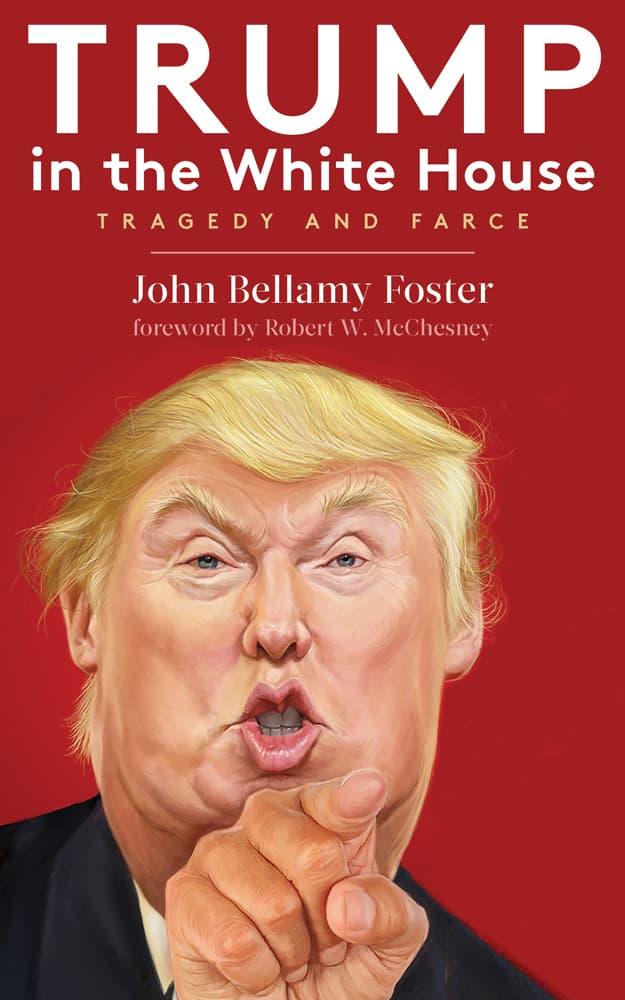 Nell’ultimo secolo il capitalismo statunitense ha avuto senza dubbio la classe dirigente più potente e con più coscienza di classe nella storia del mondo, controllando sia l’economia che lo Stato e proiettando la sua egemonia sia a livello nazionale che globale. Al centro del suo dominio ha avuto un apparato ideologico che ha insistito sul fatto che l’immenso potere economico della classe capitalista non si traduce in una governance politica e che, a prescindere dalla polarizzazione della società statunitense in termini economici, le sue pretese di democrazia rimangono intatte. Secondo l’ideologia ricevuta, gli interessi ultra-ricchi che governano il mercato non governano lo Stato, una separazione cruciale per l’idea di democrazia liberale. Questa ideologia dominante, tuttavia, si sta ora sgretolando di fronte alla crisi strutturale del capitalismo statunitense e mondiale e al declino dello stesso Stato liberaldemocratico, portando a profonde spaccature nella classe dominante e a una nuova dominazione apertamente capitalista dello Stato da parte della destra. Nell’ultimo secolo il capitalismo statunitense ha avuto senza dubbio la classe dirigente più potente e con più coscienza di classe nella storia del mondo, controllando sia l’economia che lo Stato e proiettando la sua egemonia sia a livello nazionale che globale. Al centro del suo dominio ha avuto un apparato ideologico che ha insistito sul fatto che l’immenso potere economico della classe capitalista non si traduce in una governance politica e che, a prescindere dalla polarizzazione della società statunitense in termini economici, le sue pretese di democrazia rimangono intatte. Secondo l’ideologia ricevuta, gli interessi ultra-ricchi che governano il mercato non governano lo Stato, una separazione cruciale per l’idea di democrazia liberale. Questa ideologia dominante, tuttavia, si sta ora sgretolando di fronte alla crisi strutturale del capitalismo statunitense e mondiale e al declino dello stesso Stato liberaldemocratico, portando a profonde spaccature nella classe dominante e a una nuova dominazione apertamente capitalista dello Stato da parte della destra.
Nel suo discorso di addio alla nazione, pochi giorni prima che Donald Trump tornasse trionfalmente alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha denunciato che una “oligarchia” basata sul settore dell’alta tecnologia e che si affida sul “dark money” in politica sta minacciando la democrazia degli Stati Uniti. Il senatore Bernie Sanders, nel frattempo, ha messo in guardia dagli effetti della concentrazione della ricchezza e del potere in una nuova egemonia della “classe dominante” e dall’abbandono di qualsiasi traccia di sostegno della classe lavoratrice in ognuno dei principali partiti.1 Continue reading John Bellamy Foster: La classe dominante statunitense e il regime di Trump
|


