|
|
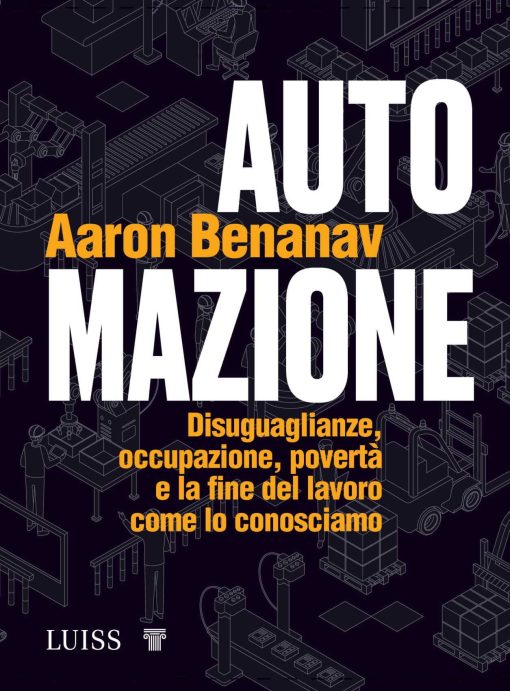 La speculazione non è la causa della nostra grande stagnazione: è il modo in cui il sistema cerca di superarla. Lo sostiene sull’ultimo numero di Jacobin magazine Aaron Benanav, professore associato di sociologia alla Syracuse University e autore di Automation and the Future of Work, libro in Italia edito dalla Luiss. Buona lettura! La speculazione non è la causa della nostra grande stagnazione: è il modo in cui il sistema cerca di superarla. Lo sostiene sull’ultimo numero di Jacobin magazine Aaron Benanav, professore associato di sociologia alla Syracuse University e autore di Automation and the Future of Work, libro in Italia edito dalla Luiss. Buona lettura!
Wall Street sussulta a ogni cambio di politica economica. Il capitale di rischio entra ed esce dall’intelligenza artificiale, dalla tecnologia della longevità, da Tesla – da qualsiasi cosa sembri la prossima grande novità. Le notizie finanziarie sembrano una giostra ad alta velocità: grafici, crolli, rimonte, token, bolle. Tutto sembra accadere contemporaneamente.
Eppure la maggior parte delle persone ha la sensazione che nulla nella propria vita si muova. Gli stipendi non si sono praticamente mossi da anni. Gli alloggi sono inaccessibili. Le infrastrutture stanno crollando. Il lavoro offre meno sicurezza, meno benefit, più ansia. Nonostante tutto il movimento ai vertici dell’economia, la vita quotidiana sembra bloccata. Questo senso di stallo non è un’illusione. Riflette qualcosa di reale: l’economia è stagnante. Nonostante tutto questo fermento, la crescita rimane lenta. Nuove industrie sono più difficili da trovare e il tenore di vita aumenta a passo di lumaca. L’economia fatica a creare buoni posti di lavoro, redditi in aumento e opportunità significative.
Continue reading Aaron Benanav: Speculazione nell’era della non crescita
Peter Thiel e i suoi amici sentono di non appartenere più alla nostra specie. Un articolo da The Nation
Tra i reazionari plutocratici, Peter Thiel, che ha fatto fortuna come cofondatore di PayPal, è un trendsetter. Nel 2016, persino i miliardari ostili al liberalismo e che condividevano le opinioni di Thiel sulla necessità di ridurre radicalmente il peso del governo per dare potere alle grandi imprese erano titubanti nel sostenere Donald Trump, vedendo il populismo del candidato come una minaccia all’ordine costituito. Lo stesso Thiel sapeva che scommettere su Trump era un azzardo, ma era una scommessa che riteneva non solo saggia, ma necessaria. Per molti anni, come chiarisce in una lunga intervista con Ross Douthat sul New York Times pubblicata giovedì scorso, Thiel temeva che la civiltà occidentale fosse entrata in un periodo di stagnazione a lungo termine negli anni ’70, che sarebbe continuato a meno di un radicale cambiamento. Questa stagnazione ha molte dimensioni: una minore crescita economica, un minor numero di scoperte scientifiche che avrebbero cambiato il mondo e un generale malessere culturale. Continue reading Jeet Heer: I miliardari stanno abbandonando l’umanità.
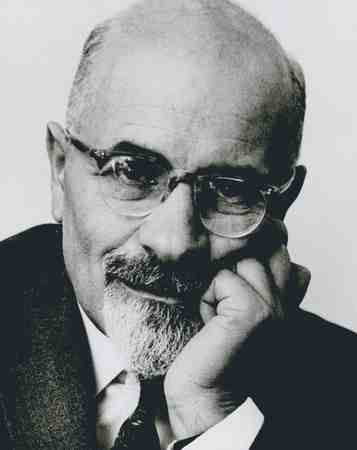 Vi propongo la traduzione di un articolo dello storico Isaac Deutscher pubblicato sul numero I/23 della New Left Review nel gennaio-febbraio 1964. Isaac Deutscher è stato un intellettuale assai importante nel dopoguerra in quanto incarnò una posizione assai critica verso lo stalinismo ma senza mai abbandonare un punto di vista marxista. Per questo divenne un punto di riferimento per la “nuova sinistra”. Ebreo polacco nacque vicino a Cracovia nel 1907. Inizialmente poeta e giornalista letterario, si unì al Partito Comunista Polacco, allora fuorilegge, nel 1926 e rimase attivo fino alla sua espulsione nel 1932 (raccontò la storia del partito in un’intervista a Karol sulla rivista di Sartre). Si trasferì a Londra nel 1939, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per intraprendere una brillante carriera giornalistica. Nel 1946 decise di diventare storico freelance, scrivendo numerosi libri, tra cui i tre volumi della ormai classica biografia di Trotsky. Segnalo un articolo di Luciano Canfora su Deutscher. Su questo blog trovate altri articoli di Deutscher: L’ebreo non ebreo, L’ultimo dilemma di Lenin e altri ne seguiranno. Vi propongo la traduzione di un articolo dello storico Isaac Deutscher pubblicato sul numero I/23 della New Left Review nel gennaio-febbraio 1964. Isaac Deutscher è stato un intellettuale assai importante nel dopoguerra in quanto incarnò una posizione assai critica verso lo stalinismo ma senza mai abbandonare un punto di vista marxista. Per questo divenne un punto di riferimento per la “nuova sinistra”. Ebreo polacco nacque vicino a Cracovia nel 1907. Inizialmente poeta e giornalista letterario, si unì al Partito Comunista Polacco, allora fuorilegge, nel 1926 e rimase attivo fino alla sua espulsione nel 1932 (raccontò la storia del partito in un’intervista a Karol sulla rivista di Sartre). Si trasferì a Londra nel 1939, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per intraprendere una brillante carriera giornalistica. Nel 1946 decise di diventare storico freelance, scrivendo numerosi libri, tra cui i tre volumi della ormai classica biografia di Trotsky. Segnalo un articolo di Luciano Canfora su Deutscher. Su questo blog trovate altri articoli di Deutscher: L’ebreo non ebreo, L’ultimo dilemma di Lenin e altri ne seguiranno.
Tengo a precisare una questione terminologica fondamentale. L’articolo del 1964 Deutscher – come divenne normale dagli anni ’20 in poi – fa riferimento usando il termine comunismo ai partiti della Terza Internazionale, cioè alla distinzione novecentesca tra comunismo e socialdemocrazia che seguì la Rivoluzione d’Ottobre e la scelta di Lenin di cambiare nel 1918 la denominazione del partito russo per marcare la distanza dagli altri partiti socialisti e socialdemocratici. Nonostante vi fossero piccolissime minoranze eretiche comuniste (bordighiani, trotzkisti, consiliaristi, ecc.) fino al 1956 e ai primi anni ’60 con il termine movimento comunista si intendevano i partiti che erano stati del Comintern e che negli anni dello stalinismo avevano mantenuto il legame con Mosca. Sul tema consiglio la lettura di Eric Hobsbawm. Successivamente con la “nuova sinistra” e la esplicitazione anche all’interno del comunismo novecentesco di visioni e prospettive assai diversificate l’uso del termine comunista ha assunto un’accezione più ampia e non più coincidente con l’identificazione con il marxismo-leninismo del PCUS. Nel terzo millennio credo che bisogna restituire alla parola comunismo una dimensione storica di lunga durata e come minimo definirlo come l’insieme di movimenti che hanno avuto origine dal Manifesto di Marx e Engels del 1848 ma la parola già circolava e i due giovani rivoluzionari la raccolsero dagli operai francesi e già terrorizzava le classi dominanti. Per Marx il comunismo moderno apparve durante le rivoluzioni borghesi come tendenza più conseguentemente democratica. Va ricordato che dai tempi di Marx e Engels fino al 1918 i due termini socialismo/comunismo e la qualifica di socialisti/socialdemocratici/comunisti venivano usati come sinonimi. Per questo considero mistificante la sentenza di “morte del comunismo” che è diventata narrazione dominante dopo l’implosione di regimi del socialismo di stato nell’est europeo. Per esempio in Italia noi che ci opponemmo alla liquidazione del comunismo lo facemmo sulla base del rifiuto della riduzione della nostra storia allo stalinismo e al modello autoritario e iperstatalista che ne derivò e alla difesa della originale elaborazione dei comunisti italiani ispirati dall’opera di Antonio Gramsci. Fu Lucio Magri nel 1990 che precisò molto bene in quale senso la nostra rifondazione si dice comunista (il suo libro ‘Il sarto di Ulm’ rimane ancora il migliore sulla storia del PCI e continuo a consigliarlo vivamente). Buona lettura! Continue reading Isaac Deutscher: Tre correnti nel comunismo (1964)
Gli eventi del 25 giugno segneranno il 75° anniversario dell’inizio della guerra di Corea, ma la verità è che gli Stati Uniti furono complici volontari di omicidi di massa in tutta la penisola. Da The Nation un articolo di Grace M. Cho, coreano-americana professoressa di sociologia al College of Staten Island CUNY e autrice di Tastes Like War e We Will Go to Jinju: A Search for Family and the Hidden Histories of the Korean War. Buona lettura!
 Nel luglio del 1950, le truppe sudcoreane giustiziarono migliaia di persone nei pressi di Daejeon, in Corea del Sud. Ufficiali statunitensi assistettero e fotografarono quello che divenne noto come il massacro di Daejeon. (foto US Army) Quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’inizio ufficiale della Guerra di Corea, nota negli Stati Uniti come “la Guerra Dimenticata”, eppure la maggior parte degli eventi commemorativi non farà altro che rafforzare la nostra dimenticanza attraverso una narrazione distorta. La narrazione è più o meno questa:
Il 25 giugno 1950 iniziò la guerra di Corea quando la Corea del Nord attraversò il 38° parallelo e invase la Corea del Sud. Fu un atto sfacciato di aggressione comunista, un attacco a sorpresa non provocato contro una nazione democratica indipendente, che spinse il presidente Harry Truman a convocare una riunione d’emergenza con le Nazioni Unite per autorizzare l’invio di forze statunitensi in Corea. Sebbene la guerra si sia conclusa in una situazione di stallo il 27 luglio 1953, le forze dell’ONU guidate dagli Stati Uniti, insieme alle forze sudcoreane, riuscirono a contenere il comunismo e a salvaguardare la libertà sia nella Corea del Sud che negli Stati Uniti.
La verità è, tuttavia, che la Corea del Sud – la nazione che gli Stati Uniti e le Nazioni Unite avevano istituito nel 1948 dopo un’occupazione americana di tre anni – non era democratica; era un brutale stato di polizia che sarebbe diventato democratico solo dopo quattro decenni di lotte popolari. Il suo primo presidente, Syngman Rhee, aveva anche pianificato di attraversare il 38° parallelo con un’invasione armata nei mesi precedenti il ??25 giugno. Le aspirazioni di Rhee non erano affatto un segreto. Furono pubblicizzate sui giornali sudcoreani e Rhee implorò gli Stati Uniti di finanziare il suo sforzo bellico. Ma nei media statunitensi, la censura era all’ordine del giorno. Il New York Times , ad esempio, soppresse volontariamente la notizia che la Corea del Sud stava pianificando di attaccare il Nord.
Continue reading Grace M. Cho: Le distorsioni morali della narrazione ufficiale della guerra di Corea
 Il drammatico cambiamento dell’imperialismo statunitense sotto la presidenza di Donald Trump, sia nel suo mandato iniziale che ancor più in quello attuale, ha creato enorme confusione e costernazione nei centri di potere istituzionali. Questa improvvisa alterazione della politica estera statunitense si manifesta nell’abbandono sia dell’ordine internazionale liberale costruito sotto l’egemonia statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia della strategia a lungo termine di allargamento della NATO e di guerra per procura con la Russia in Ucraina. L’imposizione di dazi doganali elevati e il mutamento delle priorità militari hanno messo gli Stati Uniti in conflitto persino con i loro alleati di lunga data, mentre la Nuova Guerra Fredda contro la Cina e il Sud del mondo si sta accelerando. Il drammatico cambiamento dell’imperialismo statunitense sotto la presidenza di Donald Trump, sia nel suo mandato iniziale che ancor più in quello attuale, ha creato enorme confusione e costernazione nei centri di potere istituzionali. Questa improvvisa alterazione della politica estera statunitense si manifesta nell’abbandono sia dell’ordine internazionale liberale costruito sotto l’egemonia statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia della strategia a lungo termine di allargamento della NATO e di guerra per procura con la Russia in Ucraina. L’imposizione di dazi doganali elevati e il mutamento delle priorità militari hanno messo gli Stati Uniti in conflitto persino con i loro alleati di lunga data, mentre la Nuova Guerra Fredda contro la Cina e il Sud del mondo si sta accelerando.
Il cambiamento nella proiezione di potere degli Stati Uniti è così radicale e la confusione che ne è derivata è così grande che persino alcune figure da tempo associate alla sinistra sono cadute nella trappola di considerare Trump un isolazionista, antimilitarista e antiimperialista. Per questo, il disamorato esponente della sinistra Christian Parenti ha sostenuto che Trump “non è un antiimperialista in senso lato. Piuttosto, è un istintivo isolazionista dell’America-First”, il cui obiettivo, “più di qualsiasi altro presidente recente”, è “smantellare l’impero globale informale americano” e promuovere una nuova politica estera “antimilitarista” “in opposizione all’impero”. (1)
Tuttavia, lungi dall’essere anti-imperialista, il cambiamento globale nelle relazioni esterne degli Stati Uniti sotto Trump è dovuto a un approccio ipernazionalista al potere mondiale, radicato in settori chiave della classe dirigente, in particolare nei monopolisti dell’alta tecnologia, così come nei sostenitori di Trump, in gran parte appartenenti alla classe medio-bassa.
Secondo questa prospettiva neofascista e revanscista, gli Stati Uniti sono in declino come potenza egemonica e minacciati da nemici potenti: il marxismo culturale e gli immigrati “invasori” dall’interno, la Cina e il Sud del mondo dall’esterno, mentre sono ostacolati da alleati deboli e dipendenti.
A partire dalla prima amministrazione Trump dopo le elezioni del 2016, il regime si è schierato a favore di una netta svolta a destra, sia a livello internazionale che nazionale.
Continue reading John Bellamy Foster: La dottrina Trump e il nuovo imperialismo MAGA
|
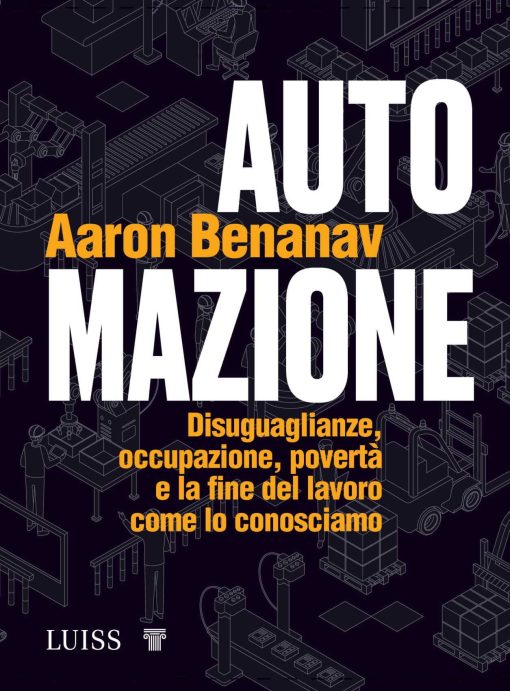 La speculazione non è la causa della nostra grande stagnazione: è il modo in cui il sistema cerca di superarla. Lo sostiene sull’ultimo numero di Jacobin magazine Aaron Benanav, professore associato di sociologia alla Syracuse University e autore di Automation and the Future of Work, libro in Italia edito dalla Luiss. Buona lettura!
La speculazione non è la causa della nostra grande stagnazione: è il modo in cui il sistema cerca di superarla. Lo sostiene sull’ultimo numero di Jacobin magazine Aaron Benanav, professore associato di sociologia alla Syracuse University e autore di Automation and the Future of Work, libro in Italia edito dalla Luiss. Buona lettura!







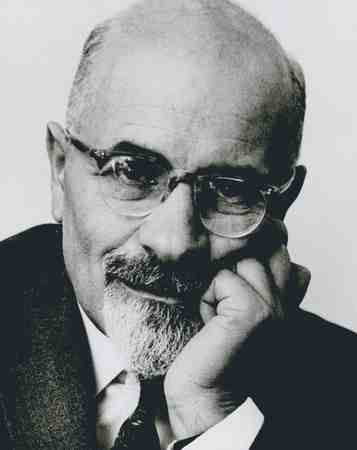 Vi propongo la traduzione di un articolo dello storico Isaac Deutscher pubblicato sul numero I/23 della New Left Review nel gennaio-febbraio 1964. Isaac Deutscher è stato un intellettuale assai importante nel dopoguerra in quanto incarnò una posizione assai critica verso lo stalinismo ma senza mai abbandonare un punto di vista marxista. Per questo divenne un punto di riferimento per la “nuova sinistra”. Ebreo polacco nacque vicino a Cracovia nel 1907. Inizialmente poeta e giornalista letterario, si unì al Partito Comunista Polacco, allora fuorilegge, nel 1926 e rimase attivo fino alla sua espulsione nel 1932 (raccontò la storia del partito in un’intervista a Karol sulla
Vi propongo la traduzione di un articolo dello storico Isaac Deutscher pubblicato sul numero I/23 della New Left Review nel gennaio-febbraio 1964. Isaac Deutscher è stato un intellettuale assai importante nel dopoguerra in quanto incarnò una posizione assai critica verso lo stalinismo ma senza mai abbandonare un punto di vista marxista. Per questo divenne un punto di riferimento per la “nuova sinistra”. Ebreo polacco nacque vicino a Cracovia nel 1907. Inizialmente poeta e giornalista letterario, si unì al Partito Comunista Polacco, allora fuorilegge, nel 1926 e rimase attivo fino alla sua espulsione nel 1932 (raccontò la storia del partito in un’intervista a Karol sulla 
 Il drammatico cambiamento dell’imperialismo statunitense sotto la presidenza di Donald Trump, sia nel suo mandato iniziale che ancor più in quello attuale, ha creato enorme confusione e costernazione nei centri di potere istituzionali. Questa improvvisa alterazione della politica estera statunitense si manifesta nell’abbandono sia dell’ordine internazionale liberale costruito sotto l’egemonia statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia della strategia a lungo termine di allargamento della NATO e di guerra per procura con la Russia in Ucraina. L’imposizione di dazi doganali elevati e il mutamento delle priorità militari hanno messo gli Stati Uniti in conflitto persino con i loro alleati di lunga data, mentre la Nuova Guerra Fredda contro la Cina e il Sud del mondo si sta accelerando.
Il drammatico cambiamento dell’imperialismo statunitense sotto la presidenza di Donald Trump, sia nel suo mandato iniziale che ancor più in quello attuale, ha creato enorme confusione e costernazione nei centri di potere istituzionali. Questa improvvisa alterazione della politica estera statunitense si manifesta nell’abbandono sia dell’ordine internazionale liberale costruito sotto l’egemonia statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia della strategia a lungo termine di allargamento della NATO e di guerra per procura con la Russia in Ucraina. L’imposizione di dazi doganali elevati e il mutamento delle priorità militari hanno messo gli Stati Uniti in conflitto persino con i loro alleati di lunga data, mentre la Nuova Guerra Fredda contro la Cina e il Sud del mondo si sta accelerando.