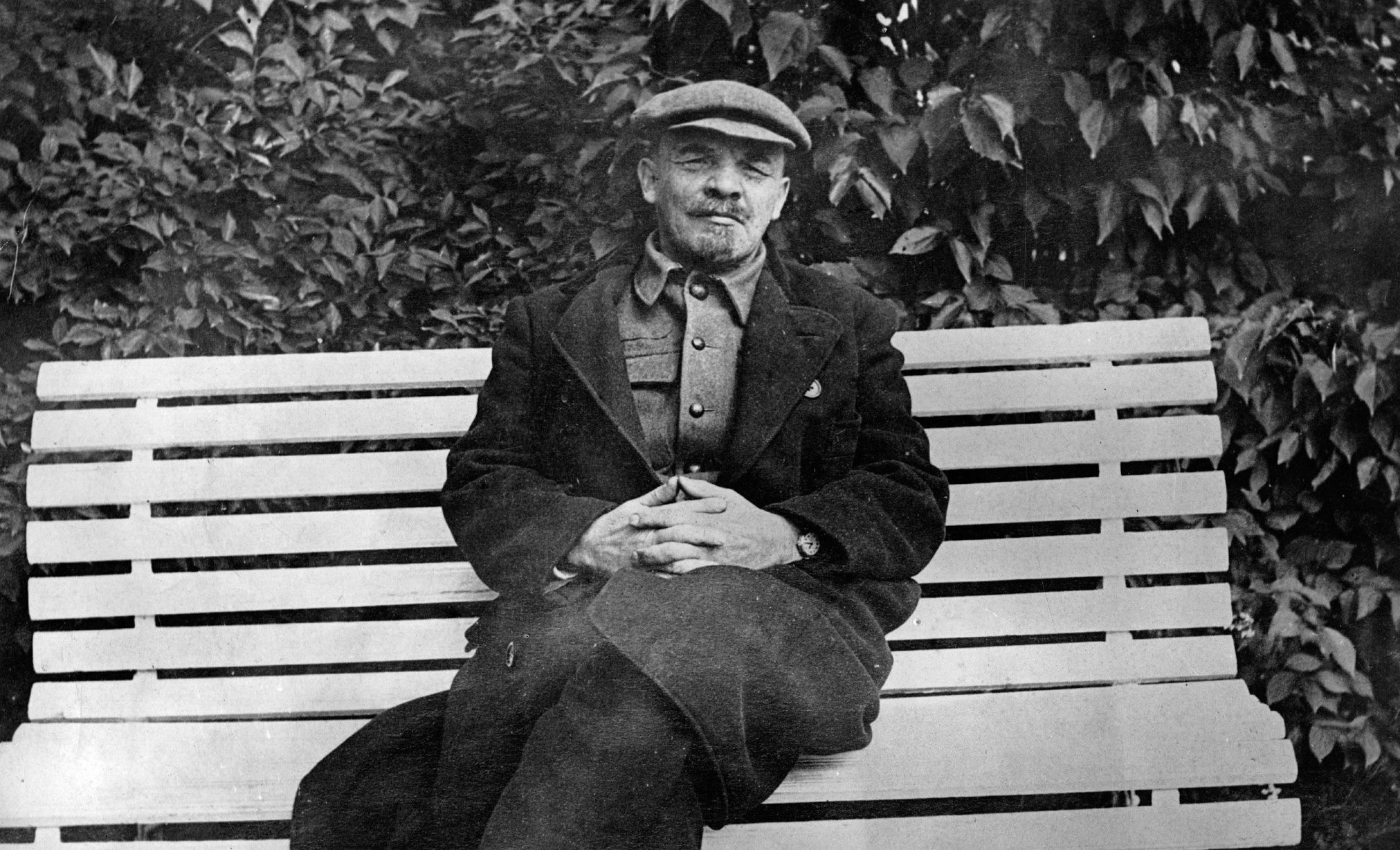
LENIN spesso invocava gli esempi di Cromwell e Robespierre; e definiva il ruolo del bolscevico come quello di un “giacobino moderno che agisce a stretto contatto con la classe operaia, come suo agente rivoluzionario”. Tuttavia, a differenza dei leader giacobini e puritani, Lenin non era un moralista. Invocava Robespierre e Cromwell come uomini d’azione e maestri di strategia rivoluzionaria, non come ideologi. Ricordava che anche come leader delle rivoluzioni borghesi Robespierre e Cromwell erano in conflitto con la borghesia, che non capiva le esigenze nemmeno della società borghese; e che dovevano risvegliare le classi inferiori, la yeomanry, gli artigiani e la plebe urbana. Sia dall’esperienza puritana che da quella giacobina Lenin trasse anche la lezione che era nella natura di una rivoluzione andare oltre se stessa per assolvere il suo compito storico: i rivoluzionari dovevano, di regola, mirare a ciò che ai loro tempi era irraggiungibile, per assicurarsi ciò che era raggiungibile.
Eppure, mentre i puritani e i giacobini erano guidati nella loro coscienza da assoluti morali, Cromwell dalla “parola di Dio” e Robespierre da un’idea metafisica di virtù, Lenin si rifiutò di attribuire validità assoluta a qualsiasi principio o legge etica. Non accettò alcuna moralità sovra-storica, nessun imperativo categorico, religioso o secolare. Come Marx, considerava le idee etiche degli uomini come parte della loro coscienza sociale, che spesso era una falsa coscienza, che rifletteva e velava, trasfigurava e glorificava certi bisogni sociali, interessi di classe e requisiti di autorità.
Fu quindi in uno spirito di relativismo storico che Lenin affrontò le questioni di moralità. Tuttavia sarebbe un errore confondere questo con l’indifferenza morale. Lenin era un uomo di forti principi; e in base ai suoi principi agì con una straordinaria dedizione disinteressata e con intensa passione morale. Fu, credo, Bucharin il primo a dire che la filosofia leninista del determinismo storico aveva questo in comune con la dottrina puritana della predestinazione che, lungi dall’ottundimento, acuiva il senso di responsabilità morale personale.
Cromwell e Robespierre divennero rivoluzionari quando furono travolti dalla corrente della rivoluzione vera e propria; nessuno dei due aveva scelto, sulla soglia della loro carriera, di lavorare per il rovesciamento del sistema di governo stabilito. Lenin, al contrario, entrò deliberatamente nel cammino del rivoluzionario un quarto di secolo prima del 1917. Dei trent’anni della sua attività politica, esercitò il potere nel corso di soli sei anni: per ventiquattro anni fu un fuorilegge, un combattente clandestino, un prigioniero politico e un esule. Durante quei ventiquattro anni non si aspettava alcuna ricompensa per la sua lotta se non la soddisfazione morale. Ancora nel gennaio 1917 disse in un incontro pubblico che lui e gli uomini della sua generazione probabilmente non sarebbero vissuti abbastanza per vedere il trionfo della rivoluzione in Russia. Cosa, allora, diede a lui, un uomo di genio politico e di straordinaria abilità in molti altri campi, la forza morale di condannarsi alla persecuzione e alla miseria al servizio di una causa il cui trionfo non si aspettava nemmeno di vedere?
Era il vecchio sogno della libertà umana. Lui stesso, il più grande realista tra i rivoluzionari, era solito dire che era impossibile essere un rivoluzionario, era solito dire che era impossibile essere un rivoluzionario senza essere un sognatore e senza avere una vena di romanticismo. L’ampliamento della libertà umana implicava per lui, in primo luogo, la liberazione della Russia dallo zarismo e da uno stile di vita radicato in una servitù della gleba secolare. In ultima analisi implicava la liberazione della società in generale dal meno ovvio ma non meno reale dominio dell’uomo sull’uomo insito nella prevalenza della proprietà borghese. Vedeva nella contraddizione tra il carattere sociale della produzione moderna e il carattere asociale della proprietà borghese la fonte principale di quell’irrazionalismo che condanna la società moderna a crisi e guerre ricorrenti e rende impossibile all’umanità persino iniziare a padroneggiare il proprio destino. Se, per Milton, gli inglesi leali al re non erano uomini liberi, e il realismo era schiavitù morale, allora per Lenin la lealtà alla società borghese e alle sue forme di proprietà era anch’essa schiavitù morale. Per lui era morale solo quell’azione che accelerava la fine dell’ordine borghese e l’istituzione della dittatura proletaria; perché credeva che solo una tale dittatura potesse spianare la strada a una società senza classi e senza stato.
Lenin era consapevole della contraddizione insita in questo atteggiamento. Il suo ideale era una società libera dal dominio di classe e dall’autorità statale; tuttavia cercò immediatamente di stabilire la supremazia di una classe, la classe operaia, e di fondare un nuovo stato, la dittatura proletaria. Cercò di risolvere questo dilemma insistendo sul fatto che, a differenza di altri stati, la dittatura proletaria non avrebbe avuto bisogno di alcuna macchina governativa oppressiva, non avrebbe avuto bisogno di alcuna burocrazia privilegiata che, di regola, “è separata dal popolo elevata al di sopra di esso e ad esso opposta”. Nel suo ‘Stato e rivoluzione’, che scrisse alla vigilia della presa del potere da parte dei bolscevichi, descrisse la dittatura proletaria come una sorta di para-stato, uno stato senza esercito permanente e polizia, uno stato costituito da “un popolo in armi”, non da una burocrazia, uno stato che si dissolve progressivamente nella società e lavora verso la propria estinzione.
Qui, in questa concezione e nel suo conflitto con le realtà della rivoluzione russa, c’era la fonte dell’unica grande crisi morale che Lenin avesse mai conosciuto: la crisi alla fine della sua vita. Dovette spesso affrontare gravi dilemmi, sottoporre le sue opinioni alla prova dell’esperienza, rivederle, tornare sui suoi passi, riconoscere la sconfitta e, cosa più difficile, ammettere l’errore; conobbe momenti di esitazione, angoscia e persino di crollo nervoso, perché al vero Lenin, non al Lenin dell’iconografia sovietica, nulla di umano era estraneo. Soffriva della più grave tensione nervosa ogni volta che doveva confrontarsi con vecchi amici come nemici politici. Mai, fino alla fine della sua vita, superò il dolore che la sua rottura con Martov, il leader dei menscevichi, gli aveva causato. Fu profondamente scosso dal comportamento dei leader dell’Internazionale socialista del 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, quando decise di marchiarli come “traditori del socialismo”. Tuttavia, in nessuna di queste e altre importanti svolte politiche egli sperimentò qualcosa che assomigliasse a una crisi morale.
Lasciatemi fornirvi altri due esempi: nel 1917 si era impegnato a convocare e sostenere l’Assemblea Costituente. All’inizio del 1918 la convocò e la sciolse. Eppure non ebbe scrupoli a riguardo. La sua lealtà era rivolta alla Rivoluzione d’Ottobre e ai Soviet; e quando l’Assemblea Costituente assunse un atteggiamento di opposizione inconciliabile a entrambi, fu in uno stato d’animo di quasi umoristica equanimità che ne ordinò lo scioglimento. Nel 1917, inoltre, si era impegnato con il suo partito a combattere per la rivoluzione mondiale e persino a condurre una guerra rivoluzionaria contro la Germania degli Hohenzollern. Ma all’inizio del 1918, a Brest Litovsk, scese a patti con il governo del Kaiser e firmò con esso una pace “vergognosa”, come lui stesso la definì. Tuttavia non riteneva di aver infranto la sua promessa: era convinto che, concludendo quella pace, avesse assicurato una tregua alla rivoluzione russa e che, per il momento, questo fosse l’unico servizio che poteva rendere alla rivoluzione mondiale.
In questa e in altre situazioni sostenne che réculer pour mieux sauter era una massima sensata. Non vedeva nulla di disonorevole nel comportamento di un rivoluzionario che si ritira dalla sua posizione di fronte a forze nemiche schiaccianti, a patto che il rivoluzionario riconosca la ritirata come una ritirata e non la travisi come un’avanzata. Questa, per inciso, era una delle differenze importanti tra Lenin e Stalin; ed è una differenza morale, la differenza tra la sincerità e la menzogna burocratica e prestigiosa. Fu proprio quando dovette inchinarsi all’opportunismo e agire “opportunisticamente” che Lenin fu più che mai ansioso di preservare nel suo partito il senso della sua direzione, una chiara consapevolezza dell’obiettivo per cui si stava sforzando. Aveva cresciuto il suo partito con un entusiasmo ardente e una disciplina severa come l’entusiasmo e la disciplina dei soldati di Cromwell. Ma era anche in guardia contro l’eccesso di entusiasmo che aveva più di una volta condotto i partiti rivoluzionari al donchisciottismo e alla sconfitta.
Guidato da questo duro realismo, Lenin fu quindi impegnato per cinque anni nella costruzione dello stato sovietico. La macchina amministrativa da lui creata aveva poco in comune con il modello ideale che aveva disegnato in ‘Stato e Rivoluzione’. Nacquero un potente esercito e una polizia politica impressionante. La nuova amministrazione riassorbì gran parte della vecchia burocrazia zarista. Lungi dal fondersi con un “popolo in armi”, il nuovo stato, come il vecchio, fu “separato dal popolo ed elevato al di sopra di esso”. A capo dello stato c’era la Vecchia Guardia del partito, i Santi bolscevichi di Lenin. Il sistema monopartitico prese forma. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice para-stato era in realtà un super-stato.
Lenin non poteva ignorare tutto questo. Eppure per circa cinque anni ebbe, o sembrò avere, una coscienza calma, senza dubbio perché sentiva di essersi ritirato dalla sua posizione sotto la schiacciante pressione delle circostanze. La Russia rivoluzionaria non poteva sopravvivere senza uno stato forte e centralizzato. Un “popolo in armi” non poteva difenderla dalle Armate Bianche e dall’intervento straniero: per quello era necessario un esercito severamente disciplinato e centralizzato. La Cheka, la nuova polizia politica, sosteneva, era indispensabile per la soppressione della controrivoluzione. Era impossibile superare la devastazione, il caos e la disintegrazione sociale conseguenti alla guerra civile con i metodi di una democrazia operaia. La classe operaia stessa era dispersa, esausta, apatica o demoralizzata. La nazione non poteva rigenerarsi da sola, “dal basso”; e Lenin vide che era necessaria una mano forte per guidarla dall’alto, attraverso un’era di transizione dolorosa di durata imprevedibile. Questa convinzione gli diede quella che sembrava essere un’incrollabile fiducia morale nel suo corso d’azione.
POI, come all’improvviso, la sua autostima crollò. Il processo di costruzione dello Stato era già molto avanzato e lui stesso si stava avvicinando alla fine della sua vita attiva, quando fu colto da un acuto dubbio, apprensione e allarme. Si rese conto di essere andato troppo oltre e che la nuova macchina del potere si stava trasformando in una presa in giro dei suoi principi. Si sentiva alienato dallo Stato che lui stesso aveva creato. A un congresso del partito, nell’aprile del 1922, l’ultimo congresso a cui partecipò, espresse in modo sorprendente questo senso di alienazione. Disse che spesso aveva la strana sensazione che ha un guidatore quando improvvisamente si rende conto che il suo veicolo non si sta muovendo nella direzione in cui lo guida. “Forze potenti”, dichiarò, “hanno deviato lo Stato sovietico dalla sua ‘strada giusta’”. Inizialmente gettò fuori questa osservazione come se fosse casualmente, a parte; ma il sentimento che c’era dietro poi lo prese fino a prenderlo completamente. Era già malato e soffriva di periodi di paralisi sclerotica; ma la sua mente lavorava ancora con implacabile chiarezza. Negli intervalli tra gli attacchi di malattia, lottava disperatamente per far muovere il veicolo dello Stato “nella giusta direzione”. Falliva ripetutamente. Era sconcertato dai suoi fallimenti. Rimuginava sulle ragioni. Cominciò a soccombere a un senso di colpa e, infine, si ritrovò in preda alla sua crisi morale, una crisi che era tanto più crudele perché aggravava la sua malattia mortale ed era aggravata da essa.
Si chiese cosa stesse trasformando la Repubblica dei lavoratori in uno stato burocratico oppressivo. Esaminò ripetutamente i familiari fattori di base della situazione: l’isolamento della rivoluzione; la povertà, la rovina e l’arretratezza della Russia; l’individualismo anarchico dei contadini; la debolezza e la demoralizzazione della classe operaia; e così via.
Ma ora qualcos’altro lo colpì con grande forza. Mentre osservava i suoi compagni, seguaci e discepoli, quei rivoluzionari diventati governanti, il loro comportamento e i loro metodi di governo gli ricordavano sempre di più il comportamento e i metodi della vecchia burocrazia zarista. Pensò a quegli esempi nella storia in cui una nazione ne conquistava un’altra, ma poi la nazione sconfitta, se rappresentava una civiltà superiore, imponeva il proprio stile di vita e la propria cultura ai conquistatori, sconfiggendoli spiritualmente. Qualcosa di simile, concluse, può accadere nella lotta tra classi sociali: lo zarismo sconfitto stava di fatto imponendo i propri standard e metodi al suo stesso partito. Fu irritante per lui dover fare questa ammissione, ma la fece: lo zarismo stava conquistando spiritualmente i bolscevichi, perché i bolscevichi erano meno civili persino di quanto lo fosse stata la burocrazia dello zar.
DOPO aver acquisito questa profonda e spietata intuizione di ciò che stava accadendo, osservava i suoi seguaci e discepoli con crescente sgomento. Sempre più spesso pensava ai dzierzhymorda della vecchia Russia, ai gendarmi, ai leader del vecchio stato di polizia, agli oppressori delle minoranze nazionali e così via. Non erano seduti ora, come resuscitati, nel Politburo bolscevico? In questo stato d’animo scrisse il suo ultimo testamento, in cui affermava che Stalin aveva già accumulato troppo potere nelle sue mani e che il partito avrebbe fatto bene a rimuoverlo dall’ufficio di Segretario generale. In quel periodo, verso la fine del 1922, Stalin stava sponsorizzando una nuova costituzione che privò le minoranze nazionali di molti dei diritti finora garantiti loro e che, in un certo senso, ristabilì la Russia “una e indivisibile” di un tempo dando poteri quasi illimitati al governo centrale di Mosca. Nello stesso periodo, sia Stalin che Dzerzhinsky, il capo della polizia politica, erano impegnati in una brutale repressione delle opposizioni in Georgia e in Ucraina.
Sul suo letto di malattia, mentre lottava contro la sua paralisi, Lenin decise di parlare e denunciare la dzierzhymorda, il grande bullo brutale, che in nome della rivoluzione e del socialismo stava facendo rivivere la vecchia oppressione. Ma Lenin non si assolse dalla responsabilità; era ormai preda del rimorso, che stava spegnendo la debole fiamma di vita rimasta in lui ma che lo aveva anche risvegliato e gli aveva dato la forza per un atto straordinario. Decise non solo di denunciare Stalin e Dzerzhinsky, ma di fare una confessione della sua stessa colpa.
Il 30 dicembre 1922, imbrogliando i suoi dottori e infermieri, cominciò a dettare appunti sulla politica sovietica verso le piccole nazioni, appunti intesi come messaggio per il successivo congresso del partito. “Sono, a quanto pare, fortemente colpevole di fronte ai lavoratori della Russia”: queste furono le sue parole di apertura, parole simili a quelle che difficilmente erano state pronunciate da nessun governante, parole che Stalin in seguito soppresse e che la Russia avrebbe letto per la prima volta solo dopo trentatré anni, dopo il XX Congresso. Lenin si sentiva in colpa di fronte alla classe operaia del suo paese perché, così disse, non aveva agito con sufficiente determinazione e abbastanza presto contro Stalin e Dzerzhinsky, contro il loro sciovinismo grande-russo, contro la soppressione dei diritti delle piccole nazioni e contro la nuova oppressione, in Russia, dei deboli e dei forti. Ora vedeva, continuò, in quale “palude” di oppressione era sbarcato il Partito bolscevico: la Russia era governata ancora una volta dalla vecchia amministrazione zarista a cui i bolscevichi “avevano dato solo una patina sovietica”; e ancora una volta le minoranze nazionali “sono state esposte all’irruzione di quell’uomo veramente russo, il grande sciovinista russo che è essenzialmente un mascalzone e un oppressore come lo è il tipico burocrate russo”.
Per trentatré anni questo messaggio è stato tenuto nascosto al popolo sovietico. Eppure penso che in queste parole: “Sono, a quanto pare, fortemente colpevole di fronte ai lavoratori della Russia” – nella sua capacità di pronunciare tali parole – ci fosse una parte essenziale della grandezza morale di Lenin.








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.