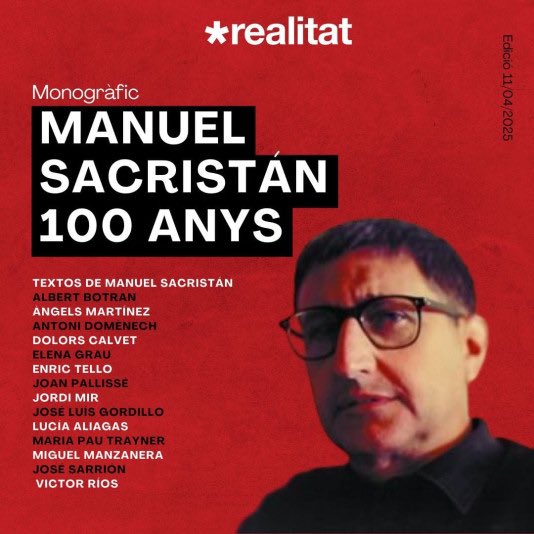
In occasione del centenario della nascita il settimanale comunista catalano *realitat propone una monografia dedicata alla figura di Manuel Sacristán, intellettuale comunista pioniere nella diffusione, nello Stato spagnolo, delle idee ecologiste e della decrescita. La monografia è stata curata dal mio amico Victor Rios, storico e ricercatore presso il Centro Studi sui Movimenti Sociali dell’Università Pompeu Fabra. Vi propongo il suo articolo che apre il numero monografico della rivista.
Ho conosciuto Manuel Sacristán quando mi sono iscritto alla Gioventù Comunista, nell’anno accademico 1967-68. La commissione di formazione del PSUC ebbe il compito di aiutarci nei nostri primi passi nel mondo del comunismo catalano. Ricordo come Sacristán ci guidava nella lettura del Manifesto del Partito Comunista, insegnandoci a leggere i nostri classici in modo critico e attuale e, quindi, insegnandoci a pensare.
Poi ho condiviso le vicissitudini vissute da lui, dai Giovani e da una parte dell’organizzazione del partito all’università. Erano tempi di forti dibattiti e controversie, tempi in cui le nostre posizioni andavano controcorrente rispetto a quelle dominanti nel PCE e nel PSUC dell’epoca, quando un euforico Carrillo presentava l’eurocomunismo come l’unica via verso il socialismo e firmava i Patti di Moncloa, definendoli una conquista storica.
I Comitati Operai per l’Educazione, il Comitato Antinucleare della Catalogna e la rivista Mientras tanto furono i successivi spazi di complicità condivisa in progetti impegnati nelle lotte e nei movimenti della fine degli anni Settanta e con un lavoro di riflessione per riformulare il progetto di emancipazione comunista alla luce dei nuovi problemi e delle sfide della civiltà. Una riformulazione che è partita dalla ridefinizione della nozione stessa di comunismo, sostituendo la prospettiva di una società dell’abbondanza materiale basata sulla crescita illimitata delle forze produttive con un orizzonte di pieno sviluppo umano che incorporasse i contributi dell’ambientalismo, del femminismo e del pacifismo nel cuore del progetto di trasformazione.
Non intendo fare ricorso ai ricordi personali delle conversazioni e delle situazioni che conservo nella mia memoria sempre più smemorata di quegli anni di rapporti personali con Manuel Sacristán. Ma vorrei riportare una testimonianza vissuta del Manolo che ho incontrato, per mettere in luce alcuni tratti della sua personalità che aiutino a spiegare l’interesse della sua carriera e del suo lavoro in uno dei tanti campi in cui ha dato contributi preziosi e attuali: quello della riaffermazione dell’identità comunista, con elementi da tenere in considerazione per fondare un comunismo necessario e possibile per il XXI secolo.
Innanzitutto metterei la sua autenticità e il suo muoversi sempre guidato dalla ricerca della verità. Capacità analitica, solidità intellettuale, passione politica, integrità morale, formavano in lui un “pacchetto integrato” che, per il livello e l’intensità raggiunti nella sua personalità, lo rendevano un riferimento singolarmente attraente, amato e rispettato da molti suoi contemporanei. (Dico per molti e non per tutti perché conto anche l’invidia di alcuni e la confusione mentale di chi lo considerava dogmatico perché aveva e praticava principi chiari, di chi vedeva rigidità nel suo rigore, o sinistrismo volontarista nella sua pratica dell’impegno politico comunista e nell’affermazione dell’importanza della soggettività rivoluzionaria nella lotta per l’emancipazione della specie umana. Per tutti costoro, sia nell’ambiente accademico che nel partito, Sacristán era, certamente, una persona scomoda).
Questa autenticità e la centralità che occupava per lui la ricerca della verità strutturarono il suo modo di stare al mondo, di vivere e di lottare per fare della Terra un luogo abitabile, libero dallo sfruttamento. Si trattava di caratteristiche legate al rigore nello studio e nella preparazione di lezioni, conferenze e materiali per l’intervento nel combattimento culturale e politico. “Mi piace cercare di sapere come stanno le cose. Mi sta a cuore il criterio di verità della tradizione del senso comune e della filosofia. Non sono disposto a sostituire le parole vero e falso con le parole valido/non valido, coerente/incoerente, coerente/incoerente; no. Per me le parole buone sono vero e falso, come nel linguaggio popolare, come nella tradizione scientifica. Proprio come in Perogrullo e in nome del popolo come in Aristotele. Quelli validi/non validi sono gli intellettuali, in questo senso, quelli che non sono seri”, commentò in un’intervista pubblicata sulla rivista mientras tanto dieci anni dopo la sua morte.
Una delle traduzioni pratiche di questo atteggiamento intellettuale ed etico consistette nell’applicare gli strumenti concettuali e metodologici della tradizione marxista all’analisi concreta della realtà dei paesi che, secondo il linguaggio dell’imperialismo della guerra fredda, costituivano il “blocco comunista”, con un uso volutamente distorto del significato della parola comunismo. Ricordo esempi di come le sue riflessioni, nate da questa analisi, acute, amare e lungimiranti, finirono per urtare la sensibilità dei militanti che, per diverse ragioni, continuavano a riferirsi acriticamente alla traiettoria dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati del Patto di Varsavia, nati nel 1955 come controparte difensiva della NATO e scioltisi nel luglio 1991.
Quelle riflessioni sullo stalinismo, sull’intervento militare in Cecoslovacchia nell’agosto del 1968, sulle ragioni della progressiva depoliticizzazione dei lavoratori di quei paesi, ecc. sono a mio avviso un punto di partenza essenziale per la ricostruzione odierna di una nozione di comunismo coerente e capace di attrarre i lavoratori e le classi popolari di tutto il mondo come alternativa alla crescente barbarie dello sfruttamento economico, dell’esclusione sociale e della disuguaglianza, dell’oppressione politica, del dominio culturale e mediatico, del degrado ecologico, del patriarcato e del militarismo sterminatore e genocida del capitalismo imperialista e autoritario dei nostri giorni.
«Dire la verità, arrivare insieme alla verità, è compiere un’azione comunista e rivoluzionaria», scrisse Gramsci nel suo testo sulla Democrazia Operaia del 1919. Manuel Sacristán adottò questa massima senza timore delle conseguenze. Il comunismo del XXI secolo non può evitarlo. La speranza, sempre necessaria, deve essere razionalmente e solidamente fondata. L’analisi della realtà, le correlazioni delle forze, le prospettive e le alleanze per resistere e avanzare non possono basarsi sull’inganno o sull’autoinganno. Per questo motivo, la formulazione di una proposta comunista per il XXI secolo non può prescindere dalle riconsiderazioni critiche e autocritiche di Manuel Sacristán sul percorso teorico e politico della tradizione stessa.
Un’altra componente rilevante del suo modo di vivere l’attività rivoluzionaria era legata alla sua concezione della politica come etica collettiva, lontana dall’opportunismo tattico e dall’iper-leadership istrionica. Questo elemento appare legato all’enfasi posta sulla dimensione etica del comunismo; al riconoscimento della necessità di rafforzare i ponti tra le migliori conoscenze scientifiche della crisi ecosociale e le diverse tradizioni culturali del movimento operaio organizzato; a un ecologismo e a un femminismo che sollevano l’urgenza di cambiare la vita quotidiana fin da ora – sia le forme di convivenza e di relazione tra le persone, sia il loro rapporto con la natura e le altre specie viventi – senza aspettare il “giorno dopo la Rivoluzione”; e la necessità di rivedere una concezione strumentale delle guerre come mezzo per conquistare il socialismo nel contesto delle attuali tecnologie belliche e della minaccia di una guerra mondiale nucleare. Tutti questi elementi fanno parte dell’eredità intellettuale, etica e politica di Manuel Sacristán e ci offrono linee guida per ripensare la prospettiva del comunismo per il XXI secolo.
Queste riflessioni possono anche consentire di instaurare un dialogo fruttuoso tra tre tipi di persone: coloro che accettano che non sia possibile superare la crisi ecosociale e di civiltà nell’attuale quadro delle strutture economiche e di potere capitaliste, ma non vedono una via d’uscita nel loro orizzonte storico individuale; altre persone che sono disposte a lavorare per un’alternativa sistemica, ma diffidano o rifiutano il nome comunismo per caratterizzarla, associandolo a “ciò che è fallito/crollato/ nei paesi dell’Europa orientale”; e altre persone che mantengono l’identità e la prospettiva comunista, come fece Manuel Sacristán fino alla sua morte. Come ha affrontato questo dialogo?
Sacristán sosteneva innanzitutto la possibilità logica ed empirica di giungere a una società comunista. Pertanto, a mio avviso, non si tratta di discutere se il comunismo rientri o meno nel nostro orizzonte storico individuale, aspetto che è molto segnato dalla nostra epoca, dal posto nel mondo in cui viviamo e dalle aspettative che in esso riponiamo, ecc., ma piuttosto di affermare la rilevanza storica della rivoluzione – che oggi non va confusa con la sua imminenza – e della sua necessità e urgenza di fronte alle dimensioni sempre più gravi della barbarie attuale. In ciò si articola la possibilità di una lotta culturale, sociale e politica capace di contrastare e rovesciare le tendenze attualmente dominanti e di aprire la strada all’avvio di un processo di transizione verso un’alternativa socialista all’altezza delle attuali sfide di civiltà, inscritta nella prospettiva di un rinnovato orizzonte comunista globale.
Sacristán pensava anche che esistesse un modo razionale per preservare la prospettiva comunista e considerarla inclusa nel nostro orizzonte. Si trattava di aggiungere un’altra funzione ai fattori classici di una strategia politica di lotta per il comunismo, fattori di cui fanno parte i partiti e i movimenti di massa. Una funzione modestamente materiale, diceva, ma importante nell’ambito culturale e valoriale: l’istituzione di possibili comunità di vita “diversa”, formate dal maggior numero possibile di elementi comunisti. I partiti stessi potrebbero promuovere queste comunità o almeno contare su di esse. E ha aggiunto che non aveva obiezioni a riconoscere, lui stesso, che questa strategia gli era stata suggerita dalla storia del cristianesimo e del gandhismo, con l’evidente rischio di elitismo che ciò comportava. (Si tratta di una riflessione contenuta in una lettera del 15 agosto 1980 all’economista Ángel Martínez González-Tablas, riprodotta nel libro Filosofia e metodologia delle scienze sociali II, a cura di Salvador López Arnal e José Sarrión).
Altre riflessioni di Manuel Sacristán sulle caratteristiche di una pratica rivoluzionaria guidata dalla finalità comunista forniscono interessanti indizi su aspetti rilevanti per il comunismo del XXI secolo. Ad esempio, quelle che possiamo trovare in testi come la sua Comunicazione al Congresso di Ecologia e Politica di Murcia del maggio 1979 sulla necessaria revisione della concezione del soggetto rivoluzionario nelle società industriali e le nuove ragioni aggiunte per continuare a vedere le classi lavoratrici come soggetto centrale per la loro condizione di sostenitrici della specie umana, conservatrici della vita e agenti essenziali del metabolismo della società con la natura. Questo aspetto si collega a un altro, sollevato sempre da Wolfgang Harich: quello della necessaria femminilizzazione del soggetto rivoluzionario e dell’idea stessa di una società giusta.
Nello stesso testo, Sacristán metteva in guardia da due proposte e percorsi pericolosi nella ricerca di alternative ai problemi della crisi ecosociale: la falsa soluzione riformista che crede di poter raggiungere attraverso riforme ciò che può rendere amico della Terra un sistema che subisce una predazione crescente e irreversibile; e, dall’altro lato, una svolta autoritaria guidata da un’aristocrazia rivoluzionaria che garantiva dispoticamente un sano metabolismo tra società e natura. Di fronte a queste proposte, la linea di condotta più razionale sarebbe quella di impiegare simultaneamente due tipi di pratiche rivoluzionarie: una che faccia riferimento al problema del potere politico, in particolare del potere statale, esplorando nuove forme di democrazia radicale e partecipativa, di potere popolare, sottolineando al contempo l’importanza dei principi di pianificazione globale e di internazionalismo. L’altra è legata alle trasformazioni urgenti volte a cercare di vivere una nuova quotidianità nei nostri rapporti umani e con la natura, nei nostri consumi, ecc., in coerenza con ciò che predichiamo e con l’orizzonte per cui lottiamo.
Il suo percorso di vita, gli esempi concreti che dimostravano la sua esigente concezione dell’impegno militante, la passione e l’attenzione all’ascolto, all’apprendimento e alla trasmissione del sapere agli operai, agli studenti e alla gioventù comunista, uniti alla severità dei suoi giudizi sulla frivolezza, sul servilismo e sull’incoerenza intellettuale, hanno dato senso e credibilità alla trilogia che, in una prima lezione di uno dei suoi rientri all’insegnamento alla Facoltà di Economia nel 1975, ci ha presentato come tre idee-guida per un dignitoso progetto di vita: Amore, Lavoro e Lotta. Amore per le persone, ma anche per la natura e la conoscenza. Il lavoro, sia nei suoi aspetti manuali che in quelli intellettuali. Lotta, cioè impegno ad agire contro le disuguaglianze, le ingiustizie e le oppressioni.
Tutto ciò mi permette di concludere che, in sintesi, l’identità comunista di Manuel Sacristán prese forma nella formulazione di un progetto etico di emancipazione umana, ecologicamente fondato e radicalmente democratico. Tre caratteristiche che devono essere presenti nel comunismo del XXI secolo. Ecco perché credo valga la pena continuare a esplorare il filo di continuità tra la vita e l’opera scritta di Sacristán e la rivendicazione di un comunismo del XXI secolo, criticamente fondato sulla conoscenza della realtà sociale del nostro tempo e capace di costruire insieme un’umanità giusta e libera su una Terra abitabile.
Riferimenti ai testi citati da Manuel Sacristán:
Comunicazione ai convegni su ecologia e politica. Murcia, maggio 1979. Pubblicato nel frattempo sul nº 1 della rivista, novembre-dicembre 1979, pp. 19-24. Testi raccolti nei libri Pacifismo , ecologia e politica alternativa , Ed. Icaria, 1987, pp. 9-17, e Ecologia e scienze sociali. Riflessioni ecologiche sulla crisi della società industriale. Prologo di Miguel Manzanera. Ed. Gli irrecuperabili, 2021, pp. 47-55.
Una conversazione con Manuel Sacristán. Di Jordi Guiu e Antoni Munné. Intervista realizzata nella primavera del 1979 per la rivista El Viejo Topo, non pubblicata su richiesta dell’intervistato. Pubblicato poi nel numero 63 della rivista nel frattempo, autunno 1995, pp. 115-129. Raccolti nei libri A proposito di Manuel Sacristán , di Salvador López Arnal e Pere de la Fuente, ed. Destiny, 1996, pp. 97-130, e Dalla Primavera di Praga al marxismo ambientalista . Interviste con Manuel Sacristán Luzón. Edizione di Francisco Fernández Buey e Salvador López Arnal, ed. Catarata, 2004, pp. 91-114)
Filosofia e metodologia delle scienze sociali (II). Edizione di Salvador López Arnal e José Sarrión Andaluz. Ed. Montesinos, 2024. (Lettera citata nel testo pp. 404-408)
Nota aggiuntiva:
I quattro volumi di testi di Manuel Sacristán intitolati Opuscoli e materiali (I. Su Marx e il marxismo; II. Articoli di filosofia; III Interventi politici; IV Letture), pubblicati dalla casa editrice Icaria tra il 1983 e il 1985, sono esauriti. Sono consultabili nella Biblioteca Virtuale dell’Archivio Josep Serradell al seguente link: https://arxiujosepserradell.
Victor Rios








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.